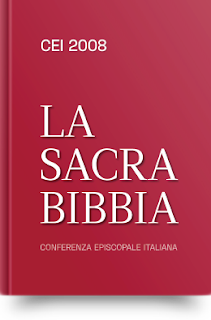Messa nella
notte
Is 9,1-3.5-6; Sal 95; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14
A Natale celebriamo il meraviglioso progetto
che Dio ha tracciato per la storia e per l’intero cosmo. Questo bambino nato a
Betlemme è il nostro Salvatore: “Oggi è nato per noi il Salvatore”. È un
annuncio che si ripete più volte in questa santissima notte.
Gesù “è nato per noi”. È logico quindi che ci domandiamo cosa arreca a noi
questa nascita. La risposta la troviamo nelle parole con cui si chiude il
vangelo di questa notte: “Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace
agli uomini, che egli ama”, e cioè pace a tutti gli uomini perché Dio ha
liberamente deciso di amarli. La prima lettura ci ricorda che tutta la storia
dell’umanità è un faticoso cammino nelle tenebre e nell’oppressione alla
ricerca di luce, di verità, di speranza e di pace. Gesù, il “Principe della
pace”, di cui parla il profeta Isaia, è la risposta definitiva di Dio alle
attese dell’umanità. “Egli - dice san Paolo nella seconda lettura - ha dato se
stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formare per sé un popolo
puro che gli appartenga”.
Nel mistero della nascita di Gesù, gli spiriti
celesti al tempo stesso che annunziano “sulla terra pace agli uomini”,
proclamano “gloria a Dio nel più alto dei cieli”. Che cos’è la gloria di Dio? È
Dio stesso in quanto si rivela nella sua maestà, nella sua potenza, nello
splendore della sua santità. Dio manifesta la sua gloria con i suoi interventi
meravigliosi nella storia. Ma, secondo san Giovanni, la gloria nascosta di Dio
è apparsa nel Cristo fra gli uomini (cf. Gv 1,14; 11,4-40) ed è riconoscibile
solo attraverso la fede (cf. Gv 2,11). In altre parole, la gloria di Dio è Dio
stesso in quanto manifesta il suo amore, un amore che si riflette sul volto di
Cristo e da lui arriva a noi. La “pace sulla terra” quindi è la manifestazione
storica della gloria di Dio, la manifestazione della volontà salvifica di Dio
in Cristo per noi. Possiamo quindi affermare anche che quando gli uomini e le
donne di questo mondo siamo nella pace, viviamo in pace, Dio è glorificato in
noi: la gloria di Dio è l’uomo redento, l’uomo che ha accolto Gesù come
Salvatore. Gesù, “Principe della pace”, appare nella storia dell’umanità come
segno di riconciliazione con Dio e con gli uomini. Con lui “la pace vera è
scesa per noi dal cielo” (antifona d’ingresso). Con Cristo inizia il tempo
della nuova ed eterna alleanza tra l’uomo e Dio, un tempo - ormai definitivo -
di pace, d’intimità e familiarità di tutti noi con Dio.
La salvezza di Dio ci viene offerta in forma
umana, nella povertà e debolezza, nel “segno” di un bambino, che assume la
nostra debolezza: “la nostra debolezza è assunta dal Verbo” (prefazio III del
Natale). Perciò la tradizione cristiana ha fatto del Natale una festa di
profonda solidarietà umana. Il Natale è un invito a riscoprire i veri valori
che danno spessore alla nostra esistenza: il senso della vita, il gusto di ciò
che è essenziale, il sapore delle cose semplici, lo stupore della vera libertà,
la voglia di costruire la propria esistenza nel servizio agli altri e
nell’impegno quotidiano per la realizzazione di un mondo riconciliato. Il buon
Natale che ci scambiamo vicendevolmente dev’essere anzitutto un augurio di pace
e di serenità intensa e profonda, che ci renda capaci di avvicinarci agli altri
per farli partecipi della nostra pace, più felici e più fratelli e sorelle, più
inseriti nella grande famiglia umana e cristiana.
Messa
dell’aurora
Is 69,11-12; Sal 96; Tt 3,4-7; Lc 2,15-20
La Chiesa celebra la manifestazione di Cristo
nella carne come una luce soprannaturale, che si è levata per il giusto e ha
recato gioia ai retti di cuore. Tutta la storia dell’umanità è un faticoso
cammino nelle tenebre alla ricerca di luce, di verità e di speranza. Il Natale
è una festa di luce che rischiara la notte delle nostre tenebre, paure e
disperazioni.
Alla luce della prima lettura, tratta dal
profeta Isaia, il mistero del Natale appare come la manifestazione dell’amore
di Dio che salva. Anche la lettura apostolica parla del manifestarsi della
bontà di Dio, salvatore nostro. San Paolo, rivolgendosi al suo discepolo Tito,
afferma che la prova massima della sua bontà e del suo amore Dio ce la fornisce
donandoci il suo proprio Figlio. Egli ha congiunto il nostro limite alla sua
infinità, ci ha restituito la possibilità di esistere nella speranza. Il Natale
celebra il dono dell’amore divino nel Cristo, rivelazione del Padre e salvezza
del mondo. Questo dono, fatto a tutti, apre il cuore dell’uomo alla speranza.
Nel brano evangelico vediamo che i primi
destinatari di questa rivelazione sono alcuni umili pastori che pascolano il
loro gregge nelle vicinanze di Betlemme. È significativo che l’annuncio della
nascita di Gesù sia dato a poveri pastori, e non ai potenti di Gerusalemme o ai
sacerdoti del tempio. Vediamo poi che la risposta dei pastori alle parole
dell’angelo è stata coerente e immediata: “Andiamo fino a Betlemme, vediamo
questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere...” E san Luca
aggiunge: “E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto
loro”. I pastori quindi, obbedendo alla rivelazione ricevuta, si recano a
Betlemme e vedono il Bambino. In questo modo, conosciuto l’avvenimento,
riferiscono, e cioè annunciano agli altri quanto essi hanno udito e visto nel
loro incontro con Gesù. Il vangelo non nominerà più i testimoni di questa prima
rivelazione. Secondo san Luca, dobbiamo a Maria, la Madre di Gesù, se si è
conservato il ricordo di queste circostanze: “Maria, da parte sua, custodiva
tutte queste cose, meditandole nel suo cuore”. Solo colui che è attento
ascoltatore della Parola può essere portatore di quell’annuncio che suscita la
meraviglia della fede.
L’eucaristia rievoca e ripresenta la morte e la
risurrezione del Cristo, ma, con il mistero della Pasqua, e in ordine ad esso,
ricorda e rinnova, in certo modo, tutta la storia della salvezza, di cui
l’incarnazione e la nascita di Gesù sono gli inizi. Il Natale del Signore segna
l’inizio di quel cammino salvifico che porta Gesù a farsi in tutti simile agli
uomini, fuorché nel peccato, fino alla morte di croce: è il cammino che, da una
parte, prepara la Pasqua e ad essa conduce e, dall’altra, riceve significato
salvifico proprio dalla Pasqua.
L’orazione dopo la comunione ci indica
l’atteggiamento con cui dobbiamo celebrare il Natale: “conoscere con la fede le
profondità del mistero, e viverlo con amore intenso e generoso”.
Messa del
giorno
Is 52,7-10; Sal 97; Eb 1,1-6: Gv 1,1-18
Nel Natale di Cristo, la Chiesa con le parole
profetiche del salmo responsoriale ci invita a lodare il Signore che ha
compiuto prodigi e ha manifestato la sua salvezza e il suo amore per la casa
d’Israele. Nel bambino di Betlemme questa salvezza si è manifestata, non solo
ad Israele, ma a tutti gli uomini della terra che possono ormai contemplarla e
accoglierla. L’ingresso del Salvatore nel mondo e nella storia provoca un
sussulto di felicità in tutti e in tutto. La gioia del Natale però sarebbe
superficiale se non fosse fondata sulla contemplazione del mistero natalizio
alla luce della fede. Ecco perché in questa messa del giorno siamo invitati a
contemplare, guidati dalla parola di Dio, le profondità di questo mistero.
La lettura evangelica è presa dal mirabile inno
che fa di prologo al vangelo di Giovanni, vera e profonda meditazione sul
mistero del Natale. San Giovanni annuncia che il Verbo di Dio si è fatto carne
ed è venuto ad abitare in mezzo a noi; ma al tempo stesso annuncia che tutti
coloro che accolgono questo bambino, il Figlio di Dio fatto carne, ricevono
anch’essi il potere di diventare figli di Dio. In Cristo ci viene offerta la
possibilità di una nuova origine, non più fondata sul sangue e sulla carne, ma
su Dio stesso. Le parole iniziali del vangelo di Giovanni “in principio”
evocano idealmente quelle parallele di Gen 1,1 riguardanti la creazione, tema a
cui fa riferimento anche la colletta quando dice: “O Dio, che, in modo mirabile
ci hai creati a tua immagine, e in modo più mirabile ci hai rinnovati e
redenti”. Il mistero del Natale riguarda quindi anche noi. Il mistero di un Dio
fatto uomo ci immerge nel mistero di noi, uomini e donne, che diventiamo figli
di Dio. Si tratta di quel “misterioso scambio” di cui parla il prefazio della
messa: il Verbo di Dio assume la nostra natura umana nella sua debolezza e
fragilità, e noi, uniti a lui in comunione mirabile, condividiamo la sua vita
immortale. La stessa dottrina esprime san Paolo in un brano che viene proposto
oggi alla nostra attenzione nella Liturgia
delle Ore: “Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio,
nato da donna, nato sotto la legge per riscattare coloro che erano sotto la
legge, perché ricevessimo l’adozione a figli” (Primi vespri, lettura breve -
Gal 4,4-5). Nel Natale noi contempliamo gli inizi della nostra salvezza. La
prima lettura, tratta da Isaia, annuncia profeticamente questo evento quando
dice: “tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio”, parole
riprese dal ritornello del salmo responsoriale, come ormai realizzate e
riproposte dall’antifona alla comunione.
San Leone Magno, contemplando il mistero
dell’Incarnazione, esclama: “Riconosci, cristiano, la tua dignità e, reso
partecipe della natura divina, non voler tornare all’abiezione di un tempo con
una condotta indegna” (Liturgia delle Ore: Ufficio delle letture, seconda
lettura). Questa stessa esortazione è implicita nel testo del prologo di san
Giovanni quando si dice che a colui che accoglie il Figlio di Dio fatto carne,
viene dato potere di “diventare” figlio di Dio: la nostra identità di figli di
Dio è inserita dentro un processo dinamico che si apre ad una crescita
progressiva e senza sosta che ci conduce verso gli spazi della vita divina. Come
dice la Costituzione Gaudium et Spes del
Vaticano II, “solamente nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce il
mistero dell’uomo (n. 22). L’umanesimo cristiano radica nel divino e
nell’eterno la nostra povera condizione mortale.
L’eucaristia che oggi celebriamo è per
eccellenza il sacrificio della nuova alleanza, il rito della nuova umanità, che
ci introduce progressivamente alla partecipazione della vita divina.


.jpg)