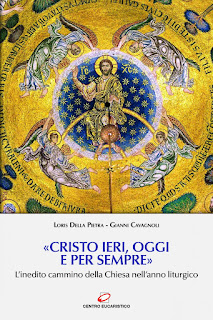di Corrado Maggioni
L’insegnamento di Paolo VI in
materia liturgica si può riassumere dicendo che egli ha voluto, guidato,
spiegato, difeso, promosso la riforma liturgica, al fine di riformare la
Chiesa, giacché è attraverso l’azione liturgica che la Chiesa sperimenta
l’incontro trasfigurante con Cristo, per Cristo e in Cristo. Senza pretesa di
abbracciare ogni aspetto se ne richiamano alcuni significativi.
La lingua corrente come “voce
della Chiesa” in preghiera
Negli anni preparatori al
concilio furono interpellati tutti i vescovi del mondo circa l’uso della lingua
volgare nella liturgia. Esistevano già alcune limitate concessioni della Sede
apostolica circa l’uso della lingua volgare nel Rituale Romano. Le chiare
decisioni dei padri del Vaticano II al riguardo furono progressivamente attuate
ed estese. Paolo VI era ben consapevole della gravità del cambiamento della
lingua, ma al contempo vedeva con lucidità che era necessario in ragione della
partecipazione del popolo alla liturgia. Ecco alcuni passaggi del suo
insegnamento a tale proposito.
Così Paolo VI si esprimeva
nello storico Angelus del 7 marzo 1965, prima domenica di Quaresima: «Questa
domenica segna una data memorabile nella storia spirituale della Chiesa, perché
la lingua parlata entra ufficialmente nel culto liturgico, come avete già visto
questa mattina.
«La Chiesa ha ritenuto
doveroso questo provvedimento — il Concilio lo ha suggerito e deliberato — e
questo per rendere intelligibile e far capire la sua preghiera. Il bene del
popolo esige questa premura, sì da rendere possibile la partecipazione attiva
dei fedeli al culto pubblico della Chiesa. È un sacrificio che la Chiesa ha
compiuto della propria lingua, il latino; lingua sacra, grave, bella,
estremamente espressiva ed elegante. Ha sacrificato tradizioni di secoli e
soprattutto sacrifica l’unità di linguaggio nei vari popoli, in omaggio a
questa maggiore universalità, per arrivare a tutti. E questo per voi, fedeli,
perché sappiate meglio unirvi alla preghiera della Chiesa, perché sappiate
passare da uno stato di semplici spettatori a quello di fedeli partecipanti ed
attivi e se saprete davvero corrispondere a questa premura della Chiesa, avrete
la grande gioia, il merito e la fortuna di un vero rinnovamento spirituale»
(Insegnamenti di Paolo VI, III [1965] 1131).
Il valore della preghiera in
lingua corrente, chiamata a esprimere la «voce della Chiesa» orante, veniva
ricordato da Paolo VI nel discorso al congresso dei traduttori dei libri
liturgici, il 10 novembre 1965, in questi termini: «Versiones, quae ante
promulgatam Constitutionem de Sacra Liturgia hic atque illic editae erant, eo
pertinebant, ut fideles ritus lingua Latina celebratos intellegerent; erant
videlicet subsidia populi, veteris huius linguae ignari. Nunc autem versiones
factae sunt partes ipsorum rituum, factae sunt vox Ecclesiae» (Insegnamenti di
Paolo VI, III [1965] 599).
L’istanza della partecipazione
alla liturgia tramite la comprensione della lingua quale «magnum principium» da
tenere in debito conto, è risuonata nel discorso di Paolo VI all’ottava
sessione del Consilium, il 19 aprile 1967, dove, così rispondeva a proposito di
una pubblicazione polemica in difesa del latino: «Essa non edifica alcuno, e
non reca perciò alcun vantaggio alla causa che vorrebbe difendere, la
conservazione cioè della lingua latina nella liturgia; questione questa degna certamente
d’ogni attenzione, ma non risolubile in senso contrario al grande principio,
riaffermato dal Concilio, della intelligibilità, a livello di popolo, della
preghiera liturgica, non che a quell’altro principio, oggi rivendicato dalla
cultura della collettività, di poter esprimere i propri sentimenti, più
profondi e più sinceri, in linguaggio vivo» (Insegnamenti di Paolo VI, v [1967]
167).
Lo stesso pensiero ribadì
Paolo VI nell’udienza generale del 26 novembre 1969, ormai a pochi giorni
dall’inizio, il 30 novembre, prima domenica di Avvento, dell’adozione
obbligatoria nella liturgia del nuovo rito della messa nelle diocesi italiane:
«Non più il latino sarà il linguaggio principale della Messa, ma la lingua
parlata. Per chi sa la bellezza, la potenza, la sacralità espressiva del
latino, certamente la sostituzione della lingua volgare è un grande sacrificio:
perdiamo la loquela dei secoli cristiani, diventiamo quasi intrusi e profani
nel recinto letterario dell’espressione sacra, e così perderemo grande parte di
quello stupendo e incomparabile fatto artistico e spirituale, ch’è il canto
gregoriano. Abbiamo, sì, ragione di rammaricarci, e quasi di smarrirci: che
cosa sostituiremo a questa lingua angelica? È un sacrificio d’inestimabile
prezzo. E per quale ragione? Che cosa vale di più di questi altissimi valori
della nostra Chiesa? La risposta pare banale e prosaica; ma è valida; perché
umana, perché apostolica. Vale di più l’intelligenza della preghiera, che non
le vesti seriche e vetuste di cui essa s’è regalmente vestita; vale di più la
partecipazione del popolo, di questo popolo moderno saturo di parola chiara,
intelligibile, traducibile nella sua conversazione profana. Se il divo latino
tenesse da noi segregata l’infanzia, la gioventù, il mondo del lavoro e degli
affari, se fosse un diaframma opaco, invece che un cristallo trasparente, noi,
pescatori di anime, faremmo buon calcolo a conservargli l’esclusivo dominio
della conversazione orante e religiosa? Che cosa diceva San Paolo? Si legga il
capo XIV della prima lettera ai Corinti: “Nell’assemblea preferisco dire cinque
parole secondo la mia intelligenza per istruire anche gli altri, che non
diecimila in virtù del dono delle lingue” (19 ecc.)» (Insegnamenti di Paolo VI,
VII [1969] 1128-1129).
La partecipazione del Popolo
di Dio
Fin dal discorso di
promulgazione della Sacrosanctum concilium, il 4 dicembre 1963, Paolo VI ebbe a
cuore di sottolineare il nesso tra liturgia e Chiesa, con risvolti anche sulla
missione che questa è chiamata a svolgere nel mondo odierno, eco in certo senso
della celebre asserzione di Sc 10 che la liturgia è «fonte e culmine della vita
della Chiesa»: «La liturgia (…) primo dono che noi possiamo fare al popolo
cristiano, con noi credente ed orante, e primo invito al mondo, perché sciolga
in preghiera beata e verace la muta sua lingua e senta l’ineffabile potenza
rigeneratrice del cantare con noi le lodi divine e le speranze umane, per
Cristo nello Spirito Santo. (…) Sarà bene che noi facciamo tesoro di questo
frutto del nostro Concilio, come quello che deve animare e caratterizzare la
vita della Chiesa».
In altri termini, vien posto
in risalto il principio che recita: «La liturgia fa la Chiesa e la Chiesa fa la
liturgia». Il primato della liturgia è perciò vitale per la Chiesa; non è
infatti clericale la liturgia, poiché riguarda e coinvolge l’intero popolo di
Dio come ricordava Paolo VI nell’udienza generale del 20 luglio 1966: «È noto a
voi tutti parimente come la prima affermazione, la prima riforma, il primo
rinnovamento, che il Concilio Ecumenico ha dato alla Chiesa, ha avuto per
oggetto la Liturgia, cioè la preghiera ufficiale della Chiesa stessa.
Ricordiamolo bene!» (Insegnamenti di Paolo VI, iv [1966] 817).
In quest’ottica, Paolo VI
aveva ben presente e chiedeva di tener ben presente «lo scopo fondamentale
della Costituzione conciliare sulla Liturgia, ch’è quello di restituire al
Popolo di Dio la partecipazione attiva alla celebrazione cultuale» (Udienza
generale del 4 gennaio 1967: Insegnamenti di Paolo VI, v [1967] 6.) E così spiegava
nell’udienza generale del 6 aprile 1966: «Partecipazione: ecco una delle più
ripetute e delle più autorevoli affermazioni del Concilio ecumenico a riguardo
del culto divino, della Liturgia; tanto che questa affermazione può dirsi uno
dei principi caratteristici della dottrina e della riforma conciliare. (…) Il
pensiero della Chiesa è chiaro: il popolo cristiano non deve semplicemente e
passivamente assistere alle cerimonie del culto divino; deve capirne il senso e
deve essere associato in modo che la celebrazione sia piena, attiva e
comunitaria (cfr. Sc 21)» (Insegnamenti di Paolo VI, iv [1966] 739-740).
Mettendo in guardia da una
idea impropria di partecipazione vista come attivismo, senza coinvolgimento
interiore che si manifesta poi in modo esteriore, Paolo VI ne spiegava già il
significato a riforma appena avviata, nell’udienza generale del 14 settembre
1966: «Noi vorremmo che ciascuno di voi raccogliesse l’invito fatto dalla
Chiesa ai suoi figli con la riforma della liturgia; riforma che soprattutto
consiste nel far “partecipare” i fedeli alla celebrazione del culto divino e
della preghiera ecclesiale. A quale punto si trova la vostra partecipazione?
Bisogna, su questo punto, raggiungere l’unanimità, per quanto è possibile! Guai
agli assenti, guai agli indifferenti, guai ai tiepidi, ai malcontenti, ai
ritardatari! La vitalità della Chiesa dipende, sotto questo aspetto, dalla
prontezza, dall’intelligenza, dal fervore dei singoli cristiani, ministri o
semplici fedeli che siano» (Insegnamenti di Paolo VI, iv [1966] 849).
Essendo inclusiva dell’intero
popolo di Dio, la liturgia si prende cura anche di chi, per distrazione o
ignoranza, non ha piena coscienza del suo mistero. Nel discorso ai membri del
Consilium del 19 aprile 1967, Paolo VI li invitava: «A delineare quel volto
della sacra Liturgia, che ne dimostri la verità, la bellezza, la spiritualità,
e che lasci sempre meglio trasparire il mistero pasquale in essa vivente, per
la gloria di Dio e per la rigenerazione spirituale delle folle distratte, ma
assetate, del mondo contemporaneo» (Insegnamenti di Paolo VI, v [1967]
168-169).
Alla vigilia dei primi
cambiamenti nel modo di celebrare la messa, nell’udienza del 19 novembre 1969
richiamava l’attenzione sul fatto che i fedeli «alla Messa sono e si sentono
pienamente “Chiesa”; (…) sappiate piuttosto apprezzare come la Chiesa, mediante
questo nuovo e diffuso linguaggio, desidera dare maggiore efficacia al suo
messaggio liturgico, e voglia in maniera più diretta e pastorale avvicinarlo a
ciascuno dei suoi figli ed a tutto l’insieme del Popolo di Dio» (Insegnamenti
di Paolo VI, VII [1969] 1123-1124).
Le celebrazioni papali
Abituati da più di
cinquant’anni a vedere il Papa presiedere la liturgia, in San Pietro come nei
più diversi luoghi del mondo, non sappiamo oggi cogliere l’impatto innovativo
di questa prassi, divenuta abituale con Paolo VI. Nella consuetudine precedente
erano assai rare le liturgie in San Pietro; la notte di Natale il Papa
celebrava in Cappella Sistina per il solo corpo diplomatico. Pio XII non ha mai
presieduto i riti della Settimana santa. Cominciò a farlo Giovanni XXIII, che
riprendendo le visite alle parrocchie romane in Quaresima vi celebrava la
messa. Fu dunque Paolo VI ad accordare rilevanza alle liturgie papali, la notte
di Natale in San Pietro, le celebrazioni pasquali, dalla domenica delle Palme
al Triduo sacro, con la Veglia in ore notturne. Volle anche presiedere
personalmente la celebrazione di alcuni sacramenti, specie nell’Anno santo del
1975.
Negli anni immediatamente successivi
il Vaticano II (1965-1969), alla luce del principio conciliare secondo cui i
riti devono risplendere per «nobile semplicità» (Sc 34) e l’arte al servizio
della liturgia (vesti e ornamenti) «piuttosto per una nobile bellezza che per
una mera sontuosità» (Sc 124), le celebrazioni pontificie, in particolare della
Cappella Papale, si sono trasformate da cerimonie derivate dalla corte
rinascimentale in celebrazioni dell’assemblea liturgica del Popolo di Dio,
presieduta dal vescovo di Roma. Il Papa vestiva e celebrava come i libri
liturgici prescrivevano per il vescovo. Se era normale fino ad allora che
nessuno comunicasse alla messa celebrata dal Papa, cominciò Paolo VI a
distribuire personalmente la comunione ai fedeli dalla prima messa celebrata in
italiano, il 7 marzo 1965.
Il Papa raggiungeva l’altare
processionalmente, preceduto dai ministranti, dai diaconi e dai concelebranti;
indossava le vesti liturgiche prescritte dall’Ordinamento generale del Messale
Romano, non rivestendo ormai più la “falda” ma un camice senza ricami, la
casula elegante per ampiezza e preziosità della stoffa, portando sulle spalle
il pallio e non più il “fanone”.
Così osserva Annibale Bugnini
tra i suoi ricordi: «La passione con la quale Paolo VI ha attuato in prima
persona la riforma liturgica, la fede con cui l’ha celebrata, sono state
certamente il più valido stimolo ai vescovi per essere essi stessi i primi
responsabili della vita liturgica delle loro diocesi, i primi celebranti» (La
riforma liturgica [1948-1975], Centro Liturgico Vincenziano, Roma 1972, pag.
789).
Il culto mariano
Se ci fu chi criticò come
“antimariana” la riforma “paolina”, si deve riconoscere che il riordino della
memoria liturgica di Maria è stato conseguente ai principi conciliari. Serviva
una lettura lucida e oggettiva della dimensione mariana della liturgia
rinnovata — Calendario, Messale, Lezionario e Liturgia delle Ore — e Paolo VI
vi provvide con l’esortazione apostolica Marialis cultus (2 febbraio 1974).
In un momento storico
difficile, tra opposte tendenze, fu come l’accensione di una lampada che aiutò
tutti a vedere meglio il posto di Maria nella pietà liturgica e non: gli
scettici trovarono convincenti indicazioni per una fondata pietà mariana; i
sostenitori vi trovarono la sintesi di quanto avrebbero voluto dire sulla
comunione orante con la Madre di Cristo e della Chiesa; i timidi vi trovarono
validi motivi per una riscoperta della presenza viva di Maria nel mistero del
culto cristiano; i nostalgici vi trovarono la spiegazione che col rinnovamento
liturgico nulla si era inteso togliere all’alma Madre di Dio, ma solo
purificare affinché risplendesse meglio ciò che doveva brillare; i fanatici vi
trovarono indicati i limiti di una corretta e fruttuosa devozione alla Vergine
Santissima; gli ostili, infine, vi trovarono il necessario richiamo a stimare,
nella preghiera comune e personale, la compagnia e l’esempio di Maria. Tra gli
insegnamenti racchiusi nell’Esortazione apostolica risaltano tre aspetti.
Anzitutto la coscienza della
dimensione “mariana” della liturgia. Eredi di un’epoca in cui la devozione
mariana trovava fiato piuttosto in “devozioni” al di fuori la liturgia e
parallele a essa, l’intento di Paolo VI fu di valorizzare la devozione a Maria
espressa anzitutto nell’azione liturgica, senza dimenticare i pii esercizi.
In secondo luogo il nesso lex
orandi - lex credendi, in ordine alla lex vivendi. La Marialis cultus ha
contribuito agli sviluppi liturgico-mariani successivi, quali l’arricchita
seconda edizione del Messale Romano Italiano (1983) e specialmente la Collectio
Missarum de beata Maria Virgine (1987), come anche l’editio tertia del Missale
Romanum (2002). Per rendersene conto basta considerare gli accenti tematici di
alcuni formulari della Collectio che attingono alla Marialis cultus, come ad
esempio Maria “discepola del Signore” (n. 10), “donna nuova” (n. 20); “maestra
spirituale” (n. 32). Assai eloquente è il prefazio del formulario n. 26 (Maria
Vergine immagine e Madre della Chiesa), intitolato «Maria modello
dell’autentico culto a Dio», la cui fonte diretta sono i numeri 17-20 della
Marialis cultus. Non è sfuggito a Paolo VI — spesso vi ritorna — che venerare
Maria significa vivere come lei: «È impossibile onorare la Piena di grazia
senza onorare in se stessi lo stato di grazia, cioè l’amicizia con Dio, la
comunione con lui, l’inabitazione dello Spirito» (Mc 57).
Infine, la sollecitudine per
la pietà popolare, che sa incoraggiare e orientare, accompagnando la crescita
armonica della vita spirituale. Nel rilevante ambito della pietà popolare, la
Marialis cultus ha il grande merito di aver osservato luci e ombre, indicando
la strada da percorrere per il rinnovamento e la purificazione della pietà
popolare in genere, le cui linee guida sono poi maturate con il Direttorio su
pietà popolare e liturgia (2002).
Fonte: L’Osservatore Romano
23 luglio 2019