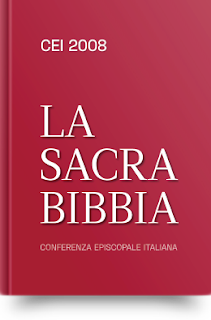Il Lezionario della Messa (Ordo Lectionum
Missae [OLM]) va venerato come la Parola di Dio: la liturgia stessa ce lo
insegna, quando circonda il libro dei Vangeli con tanti segni di venerazione
(incenso, bacio, intronizzazione sull’altare e sull’ambone).
Il Lezionario contiene la Parola che Dio
rivolge a tutta l’assemblea. “I libri, dal quale si desumono le letture della
Parola di Dio […] devono suscitare negli ascoltatori il senso della presenza di
Dio che parla al suo popolo. Si deve quindi procurare che anche i libri,
essendo nell’azione liturgica segni e simboli di realtà superiori, siano
davvero degni, decorosi e belli” (OLM 35).
Il Lezionario è un mezzo in più, tra i gesti
simbolici, per mostrare la nostra comprensione e stima della Parola di Dio.
“Poiché la proclamazione del Vangelo costituisce sempre l’apice della Liturgia
della Parola, la tradizione liturgica, sia occidentale che orientale, ha sempre
fatto una certa distinzione fra i libri delle letture. Il libro dei Vangeli
veniva infatti preparato e ornato con massina cura, ed era oggetto di
venerazione più di ogni altro libro destinato alle letture” (OLM 36).
All’inizio della celebrazione della Messa il
diacono porta solennemente il libro dei Vangeli. Questo gesto indica che la
Parola di Dio convoca l’assemblea e illumina la sua fede. L’Evangeliario viene,
poi, deposto, chiuso, sull’altare. Il vescovo che presiede bacia l’altare e
l’Evangeliario al termine della processione di ingresso. Altare e libro: il
nostro duplice incontro con Cristo, parola e alimento della comunità cristiana.
Duplice mensa alla quale siamo invitati.
Al momento della proclamazione del Vangelo, il
diacono prende l’Evangeliario dall’altare: come il pane e il vino eucaristici
sono presi dall’altare perché i fedeli si nutrano del corpo di Cristo, così
anche il Vangelo è preso dall’altare affinché i fedeli si nutrano dalla parola
di Cristo. Poi, accompagnato da accoliti con incenso e candelieri, si pone in
marcia la processione verso l’ambone. Lì il diacono apre il libro. Prima di
proclamare la lettura, il libro del Vangelo viene incensato. La proclamazione
inizia con il triplice segno della croce. Il diacono tocca prima il libro,
tracciandovi un piccolo segno di croce. E poi lo fa su sé stesso: sulla fronte,
sulle labbra e sul petto, a significare l’accesso della parola evangelica nelle
facoltà fondamentali della persona (intelletto, linguaggio e volontà). E’
l’espressione di un desiderio: che questa Parola che risuona in mezzo a noi
penetri nella nostra persona, e illumini veramente i nostri pensieri, le nostre
parole, i nostri sentimenti e le nostre azioni. Finita la proclamazione, colui
che ha proclamato il Vangelo prende il libro nelle sue mani e lo bacia: un
bacio a Cristo che ci ha parlato. Nel frattempo, dice sottovoce: “la parola del
Vangelo cancelli i nostri peccati”, chiede cioè che questo Vangelo sia
strumento di salvezza per noi, distruggendo il male che sempre ci insidia.
Nelle celebrazioni più solenni, il vescovo può impartire la benedizione al
popolo con l’Evangeliario (cfr. Ordinamento generale del Messale Romano,
n. 175).
Il Lezionario o l’Evangeliario rimane aperto
sull’ambone. Chiuderlo non avrebbe significato. Il libro aperto, alla vista del
popolo, continua ad illuminare il resto della celebrazione eucaristica e tutta
la vita della comunità.
Il Messale italiano affianca all’antifona alla
comunione dell’edizione tipica latina un’antifona proveniente dal vangelo del
giorno. In questo modo si ricorda l’unicità della tavola del Cristo pane di
vita che si offre come nutrimento ai credenti nel suo corpo scritturistico e
nel suo corpo eucaristico.
Accanto all’altare, abbiamo l’ambone (che
significa “luogo elevato”, da anabaínein,
“salire”), luogo della proclamazione della Parola. Dopo secoli di oblio, il
ritorno dell’ambone all’interno dello spazio liturgico è segno della riscoperta
del valore della Parola di Dio nella vita della Chiesa. L’ambone è, nella prima
parte della celebrazione – come l’altare nella seconda – il centro
dell’attenzione di tutta l’assemblea.